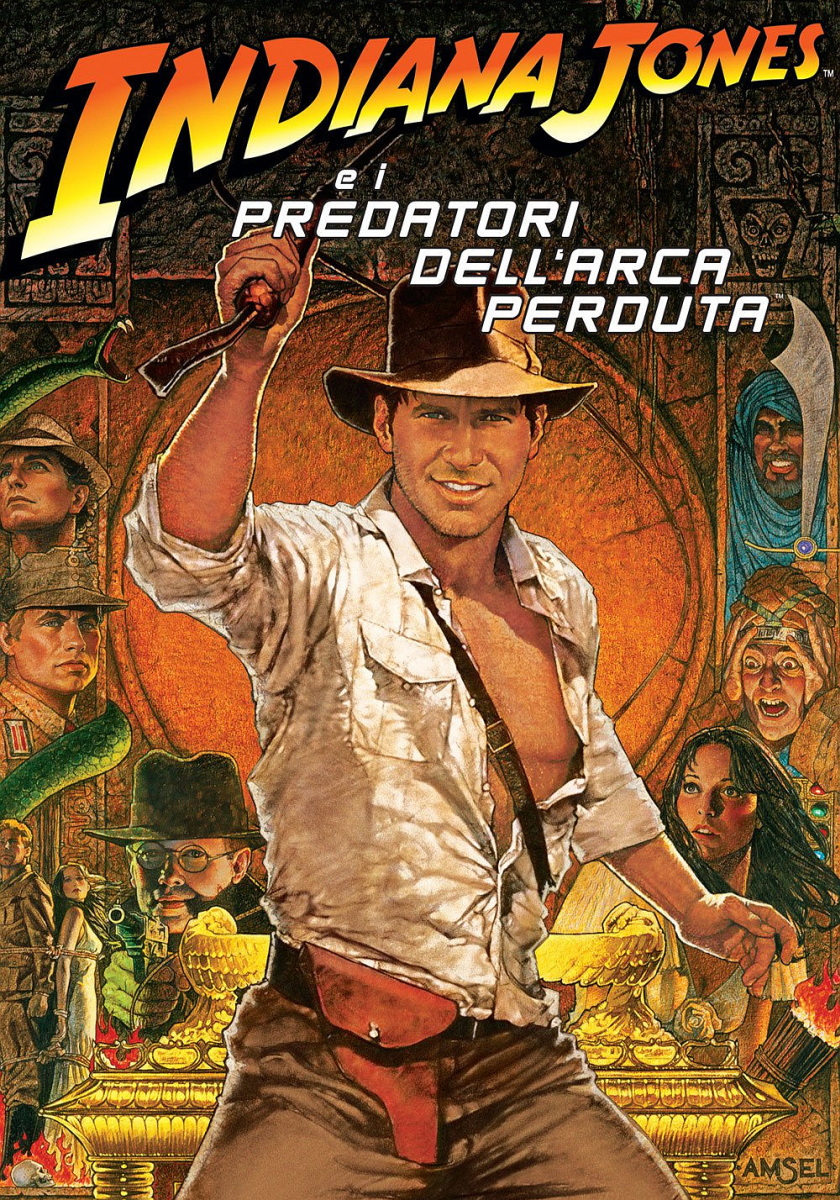Immaginate un tavolo da gioco, il feltro verde illuminato da una luce fioca, carte che scivolano tra le dita di un uomo che vive di bluff e istinto. Questo è Charley Babbitt, interpretato da un Tom Cruise all’apice del suo carisma anni ’80, un egoista incallito che non ha tempo per gli altri, figuriamoci per un fratello mai conosciuto. Ma quando il destino, con la morte del padre, gli scarica addosso Raymond (Dustin Hoffman), un fratello maggiore autistico, la sua vita prende una piega inaspettata. Rain Man (1988), diretto da Barry Levinson, non è solo un film: è un viaggio, un’odissea emotiva e una macchina da Oscar che, pur con qualche trucco da prestigiatore, ha lasciato un segno indelebile nel cinema.
Un’eredità scomoda e un viaggio che cambia tutto
La premessa di Rain Man è semplice ma potente: Charley, un commerciante di auto sull’orlo del fallimento, scopre che l’eredità paterna – milioni di dollari – è stata destinata a Raymond, un uomo che vive in un istituto e che Charley non sapeva nemmeno esistesse. Tutto ciò che gli resta è una vecchia Buick Roadmaster decappotabile, simbolo di un rapporto col padre mai davvero coltivato. Furioso e determinato a ottenere ciò che ritiene suo, Charley “rapisce” Raymond, sperando di usarlo come leva per il denaro. Ma Raymond non è un semplice ostacolo: è un genio matematico, capace di calcoli complessi a mente e di memorizzare elenchi telefonici (fino ai suoceri di Hoffman, in un cameo meta-cinematografico). È anche, però, un uomo intrappolato in routine rigide, spaventato dal cambiamento, e questo costringe Charley a rallentare, a guardarlo, a capirlo.
Il viaggio on the road che ne segue – da Cincinnati a Los Angeles, con deviazioni in casinò e motel polverosi – è il cuore del film. È qui che Rain Man si trasforma da dramma familiare a riflessione sulla connessione umana. Charley, inizialmente cinico e irritato, scopre che Raymond non è solo una “macchina” di numeri, ma un fratello. La scena in cui Raymond, terrorizzato da un allarme antincendio, si rifugia nell’abbraccio di Charley è un pugno allo stomaco: per la prima volta, i due si toccano davvero, non solo fisicamente ma emotivamente. Hoffman, con un’interpretazione che rasenta la perfezione, dà a Raymond una dignità e una complessità che evitano lo stereotipo dell’“idiota savant”. Cruise, d’altro canto, regge il confronto con un’energia nervosa, mostrando un’evoluzione sottile ma credibile.
Un poker d’assi: i quattro Oscar e il successo al botteghino
Rain Man non è solo una storia ben raccontata: è un fenomeno. Con 412,8 milioni di dollari incassati worldwide, si piazza al sesto posto tra i film di maggior successo degli anni ’80. I quattro Oscar – miglior film, regista, attore protagonista (Hoffman) e sceneggiatura originale – sono la ciliegina su una torta che Hollywood ha divorato. La chimica tra Hoffman e Cruise è elettrizzante, e la regia di Levinson bilancia sapientemente momenti di leggerezza (le scene al casinò, dove Raymond conta le carte come un supercomputer umano) con attimi di profonda intimità.
Eppure, c’è un “ma”. Il film, come suggerisce il testo iniziale, è un po’ troppo “furbetto”. La sceneggiatura di Ronald Bass e Barry Morrow sa esattamente quali tasti emotivi premere, e a volte lo fa con una precisione quasi calcolata. La scoperta dell’autismo di Raymond, le sue abilità straordinarie, il viaggio che “guarisce” il cuore di Charley: tutto è confezionato per commuovere e stupire, senza lasciare troppo spazio all’ambiguità. È un film che vuole piacere, e ci riesce, ma a costo di sembrare, in certi momenti, un prodotto più che un’opera d’arte.
Dettagli che fanno sorridere (e riflettere)
Rain Man è anche un film pieno di curiosità che lo rendono ancora più affascinante. La targa della Buick, MI 3762 4, è un omaggio alla data di nascita di Tom Cruise (3 luglio 1962). La memoria di Raymond include i nomi di Marsha e William Gottsegen, i suoceri di Hoffman, un tocco di ironia che strizza l’occhio al pubblico. E poi c’è la scena degli incidenti aerei, con Raymond che elenca statistiche catastrofiche ma loda la Qantas come unica compagnia sicura: tagliata dalle versioni proiettate in volo (ovviamente!), è un esempio di come il film giochi con la realtà in modo intelligente.
Un aneddoto interessante riguarda il casting: Hoffman doveva inizialmente interpretare Charley, ma dopo aver conosciuto persone autistiche, insistette per il ruolo di Raymond. Una scelta che si rivelò azzeccata: la sua performance, costruita su gesti ripetitivi, sguardi sfuggenti e una voce monocorde, è tanto tecnica quanto profondamente umana. Hoffman non imita l’autismo, lo abita.
Perché Rain Man è ancora rilevante?
A distanza di oltre trent’anni, Rain Man resta un film che parla a tutti. È una storia di redenzione, certo, ma anche una riflessione su cosa significhi essere diversi in un mondo che spesso non capisce. Raymond non è un “problema” da risolvere, ma una persona con cui connettersi, e il film, pur con le sue semplificazioni, ha contribuito a portare l’autismo al centro del discorso pubblico. Non è perfetto: alcuni critici hanno sottolineato che l’autismo di Raymond è romanzato, e il finale, con Charley che “impara la lezione”, può sembrare troppo pulito. Ma la forza del film sta nella sua capacità di farti ridere, commuovere e pensare, tutto nello stesso respiro.
Se non l’avete mai visto, recuperatelo. E se l’avete già visto, riguardatelo: vi accorgerete che, come un buon vino, Rain Man migliora con il tempo. È un film che ti prende per mano, ti porta in viaggio e ti lascia con una domanda: chi è il vero “uomo della pioggia” della tua vita? Qualcuno che, senza volerlo, ti ha cambiato per sempre.